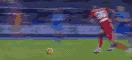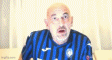Ricordo dell’unica volta in cui l’Atalanta riuscì a vincere la Coppa Italia, nel 1963.
Nel momento esatto in cui Alban Lafont si è accartocciato goffamente su un destro non irresistibile di Alejandro Gomez, un telefono ha iniziato a squillare. L’Atalanta in finale di Coppa Italia è una notizia un po’ originale che non ha bisogno di alcun giornale, ma sono i giornali ad aver bisogno di eroi. E ce ne è uno, nei 112 anni di storia della “Dea”, che più di tutti gli altri ha legato il proprio nome a quello di una finale.
Era il figlio dell’oste di Lallio, quattromila anime a circa 5 chilometri da Bergamo, ed era cresciuto con sei sorelle e due fratelli. «C’era una miseria nera, le mie sorelle dormivano in una camera: quattro in un letto matrimoniale, due sui lettini. Mio fratello Marcello stava in una camera del palazzo Pesenti, che era uno dei padroni del paese, l’altro dai nonni. L’osteria non bastava, le sorelle davano una mano al papà ma si faticava ad andare avanti, e il comune ci dava il contributo». Angelo era nato nel 1941, durante la guerra, e nessuno aveva il coraggio di scommettere sul suo futuro. Probabilmente, neanche lui. «Facevo diventare tutti matti. A tredici, quattordici anni, ero uno senza legge. Rubavo la frutta ai contadini e quelli mi inseguivano fino a casa, fino all’osteria. “Tuo figlio è un delinquente, è un farabutto”, dicevano. E allora i miei mi picchiavano. Mi picchiava mia madre, mi picchiavano le mie sorelle. Giù botte. Dormivo con mio padre e mia madre, prendevo subito sonno, ero stanchissimo. Mio padre saliva tardi, mi svegliavo e lui mi guardava: “Delinquente, tu nella vita non farai mai niente”. E, già che c’era, giù un paio di sberle».
Il calcio gli ha salvato la vita, gli ha dato un futuro, un posto nella storia. Partendo dall’oratorio di Lallio, dove lo aveva notato un prete, don Antonio. Il padre lo andava a vedere giocare di nascosto, anche senza capire nulla di calcio, nei momenti di tregua dal lavoro in osteria, dove dispensava vino e sedava le risse che infiammavano l’Italia in quegli anni tra democristiani, comunisti e missini. Da quelle parti, giocare bene a calcio voleva dire soltanto una cosa: prima o poi, si sarebbe finiti all’Atalanta. Viene venduto alla “Dea”, ma al mattino lavorava in fabbrica: come si fa a diventare davvero calciatori senza aver fatto il settore giovanile, si chiedeva lo scapestrato diciannovenne sulla corriera da Lallio a Bergamo. Un giorno, dalla fabbrica della Magrini, era partita una telefonata verso i piani alti dell’Atalanta: «Cosa pensate di fare con questo ragazzo? O mi lavora tutta la giornata oppure ve lo tenete a giocare». Dall’altra parte, pochi dubbi: teniamo.
Sono passati anni, lustri, decenni. E quando Lafont ha combinato quel mezzo disastro, è tornato in mente a tutti il ragazzo di Lallio, diventato leggenda – tre scudetti, un Europeo, una Coppa dei Campioni, due Intercontinentali – partendo dal niente e passando per l’Atalanta. Lì, col primo nerazzurro della sua vita addosso, ha vinto il trofeo che ha dato inizio a tutto. La Coppa Italia 1962/63, l’unica della storia della “Dea”, l’ha marchiata a fuoco il figlio dell’oste di Lallio, “Domingo”, quello che tutti hanno ricominciato a cercare all’improvviso. Questa è la storia di quella squadra, di quel torneo e del suo capocannoniere, Angelo Domenghini.
Il cammino fino alla semifinale
Nel 2019 ancora si discute del format ideale per la Coppa Italia, e nel 1962 la storia non è molto diversa. Il torneo aveva ripreso quota da poco: lo stop bellico aveva frenato lo slancio della competizione, nata di fatto nel 1935 dopo la sua prima versione embrionale, quella vinta dal Vado nel 1922 in pieno scisma del calcio italiano. Soltanto nel 1958, quindici anni dopo l’ultima edizione, vinta dal Torino il 30 maggio del 1943, si era ripartiti con la vittoria della Lazio, proseguendo per tre stagioni con una formula che prevedeva la finale a fine estate, a settembre, per poi riallineare i calendari in occasione della stagione 1960/61, con il successo della Fiorentina. In queste primissime edizioni, la Coppa Italia è un torneo che sa riservare sorprese. Nel 1941 aveva stupito tutti il Venezia, che presentava però due ragazzi niente male in rosa: Ezio Loik e Valentino Mazzola, future colonne del Grande Torino. Il 21 giugno 1962, con una vittoria a sorpresa, il Napoli aveva piegato la resistenza della SPAL, diventando l’unica squadra di Serie B, insieme al Vado nel 1922, a vincere la competizione.
Ai blocchi di partenza della Coppa Italia 1962/63 si presentano trentotto squadre: le diciotto di A e le venti di B. Non sono previsti gironi, e dopo il primo turno ne restano diciannove: delle “big”, vita facile per Juventus, Roma, Fiorentina, Genoa e Inter. Il Torino passa soltanto grazie al lancio della monetina contro la Triestina, lo stesso capita alla Lucchese contro il Mantova. Il Napoli, detentore del trofeo, viene beffato dal Messina, ed esce in fretta anche l’altra finalista, la SPAL, affossata dal Catanzaro. Il Milan arranca ma supera il Parma di misura, l’Atalanta viene citata soltanto marginalmente dalle cronache dell’epoca dopo aver battuto ai supplementari il Como.

L’analisi di Paolo Bertoldi evidenzia le sei eliminazioni dei club di Serie A. Al suo interno, un lungo passaggio sull’esordio del brasiliano Germano nel Milan: è riferita a lui la frase «è soltanto tecnico il problema dei calciatori negri»
Con diciannove club qualificati al turno successivo, per l’organizzazione iniziano i problemi. La soluzione adottata è quella di ben tredici “bye” (termine di origine tennistica che indica il salto direttamente al turno successivo, senza disputare la partita): per il secondo turno scendono in campo solamente sei squadre, scelte tramite sorteggio. Il Genoa supera a domicilio la Fiorentina, la Roma batte 3-1 il Catanzaro, la Juventus è corsara in casa del Foggia & Incedit. L’Atalanta aspetta il Catania negli ottavi di finale e in pochi si preoccupano degli “orobici”, che pure hanno chiuso al sesto posto la stagione precedente, con Ferruccio Valcareggi in panchina.
È stato un triennio di consolidamento, quello agli ordini del tecnico triestino. Un periodo aperto da un buon undicesimo posto in A nell’anno successivo alla promozione e dalla brutta notizia del ritiro prematuro di Stefano Angeleri, rimasto a lungo recordman di presenze in nerazzurro (316, superato in epoca recente soltanto da Gianpaolo Bellini). Una squadra via via ritoccata nel corso degli anni, fino al brillante sesto posto del 1962, anno in cui la “Dea” aveva raggiunto anche la semifinale di Mitropa. A quella cavalcata aveva preso parte anche una futura leggenda del club, Fermo Favini, assente però nella rosa della stagione successiva. Non c’è più nemmeno Valcareggi, sedotto dalla Fiorentina. Al suo posto, dopo un lungo girovagare per l’Italia (Baracca Lugo, Ponte San Pietro, Parma, Sampdoria, SPAL, Bari e Foggia), un vecchio cuore nerazzurro come Paolo Tabanelli. Nel suo piano, Domenghini deve iniziare a ritagliarsi un ruolo di maggiore responsabilità. In porta c’è un nome iconico: Pier Luigi Pizzaballa, destinato a entrare nella storia del calcio un anno più tardi per l’introvabilità della sua figurina Panini. È uno dei tanti bergamaschi di quella squadra, insieme a capitan Gardoni, Pesenti, Roncoli, Rota, Gentili e Nodari, e si è trovato titolare all’improvviso, complice un grave infortunio subito da Cometti.
Per gli ottavi di finale, l’organizzazione non prevede più il lancio di monetina in caso di parità ma i calci di rigore. Vi ricorrono Torino ed Hellas Verona per avere la meglio su Bologna e Lucchese, mentre iniziano a saltare le big. Il Milan perde in casa con la Sampdoria, l’Inter viene eliminata a domicilio dal Padova, formazione di Serie B, e la Roma si fa beffare dal Genoa. L’Atalanta fa il suo dovere contro il Catania, sfruttando anche il palese disinteresse dei siciliani per la competizione. Il tecnico Di Bella lo dichiara apertamente alla vigilia, lasciando fuori Szymaniak, Battaglia e molti altri titolari. «Ma che interesse possiamo avere nella Coppa Italia? Non ci facciamo neppure i soldi per pagare le spese di queste lunghe trasferte, mentre corriamo grossi rischi di rovinare i nostri giocatori migliori». Gli etnei scendono in campo con un sedicenne, tale Malerba. Fa turnover anche Tabanelli, lasciando a riposo Mereghetti, Domenghini, Magistrelli e Calvanese. Decide una doppietta di Christensen, 2-1 il risultato finale, con qualche nube sull’arbitraggio: «Strana direzione di Varazzani, un arbitro che applica approssimativamente il regolamento», scrive Giulio Accatino nella cronaca del match. «Convalida i goal atalantini viziati il primo da un netto fallo di Da Costa ai danni di Benaglia e il secondo da un fuorigioco palese di Christensen».
Restano otto squadre in ballo e gli accoppiamenti dei quarti sono i seguenti: Bari-Genoa, Juventus-Hellas Verona, Sampdoria-Torino, Atalanta-Padova. I primi a scendere in campo sono proprio i bergamaschi: vita facilissima, 2-0 e semifinali in tasca. La notizia clamorosa è l’eliminazione della Juventus (0-1) per mano dell’Hellas. Avanza anche un’altra formazione di B, il Bari, che ha bisogno dei supplementari per eliminare il Genoa. Proprio i pugliesi sono l’avversario dell’Atalanta in semifinale, mentre il Torino pesca il Verona. Stavolta si fa sul serio, non c’è turnover che tenga.
La “Dea” scende in campo con Pizzaballa, Pesenti, Nodari; Nielsen, Gardoni, Colombo; Domenghini, Da Costa, Calvanese, Mereghetti, Magistrelli. Il Bari tiene benissimo il campo per un tempo, non mostrando di accusare la differenza di qualità. Nella ripresa, Tabanelli ordina l’assalto, consentendo anche a Colombo di sganciarsi più spesso in avanti. È proprio lui a raccogliere un assist di Nielsen e a colpire il palo con una conclusione potentissima, ribadita in rete da Dino Da Costa a porta sguarnita. Figlio di un autista di filobus, divenuto in fretta stellina del Botafogo, Da Costa ha un passato in un tridente d’attacco atomico, con Garrincha e Luis Vinicio (“‘O lione”, come sarebbe stato chiamato nella sua esperienza napoletana), ed è stato portato in Italia dalla Roma, con cui ha vissuto cinque anni fantastici. Gli osservatori lo avevano visto all’opera in una tournée italiana del club e ne avevano immediatamente suggerito l’acquisto a Renato Sacerdoti nel corso della sua seconda presidenza giallorossa: la prima si era interrotta bruscamente nel 1935 poiché, in quanto ebreo, venne arrestato e mandato al confino, nonostante l’indubbia vicinanza al Partito Nazionale Fascista: non mancano le foto di Sacerdoti che, in alta uniforme, prende parte alla Marcia su Roma del 28 ottobre 1922. Sfuggito alle deportazioni grazie a un rocambolesco nascondiglio in un convento, Sacerdoti aveva quindi deciso di rifare grande la Roma, e Da Costa era stato un tassello fondamentale nella sua opera di rinascita.
Il campionato finisce il 26 maggio e l’Inter è campione d’Italia, mentre l’Atalanta è ottava, con Da Costa miglior realizzatore della squadra: battendo il Napoli all’ultima giornata, la squadra nerazzurra condanna i partenopei alla retrocessione. È una partita che lascia un’onda polemica, con gli azzurri pronti ad accusare gli avversari di eccessivo impegno: «Nell’ultima gara, per ammissione esplicita di taluni fra i giocatori, l’Atalanta ha messo l’impegno di chi ricordava certe poco simpatiche accoglienze ricevute nel girone d’andata sul campo partenopeo. È strano dover dare questa cruda spiegazione per il comportamento perfettamente in regola con la correttezza sportiva della compagine bergamasca, ma è l’ambiente di una parte del calcio italiano che vuole questo», si legge su La Stampa del 27 maggio 1963. «Vi sono tipi sempre pronti al sospetto: se una squadra non si impegna abbastanza è pagata per perdere, se si impegna a fondo sarà bene che spieghi chiaramente perché lo fa, onde non vedersi accusata di chissà quali intrallazzi a vantaggio di terzi», una fotografia che ci dice quanto poco sia cambiato il modo di interpretare il calcio nonostante il tempo che passa.
La vittoria
Sono giorni caldi per la Lega, che sta cercando disperatamente un modo per dare lustro alla Coppa Italia. Scottato dalle due semifinaliste di Serie B, il presidente della Lega Calcio, Giorgio Perlasca, decide di garantire un posto in semifinale nell’edizione 1963-64 a Milan, Inter, Juventus e alla vincitrice del torneo. Tra gli inviati al seguito per la finale di Milano, ce ne è uno d’eccezione: è Vittorio Pozzo, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana. Già allora, esattamente come oggi, si dibatteva in maniera accesa sul fascino della competizione: «Ogni volta che assistiamo alla finale di Coppa d’Inghilterra, manifestazione fra le più grandiose a cui dia luogo il giuoco della palla rotonda, ci torna naturale alla mente il quesito: perché non sia possibile di portare la consimile competizione italiana a un grado di successo che possa equivalere a quella inglese. Tentativi sono stati fatti, ma da noi la Coppa Italia non è mai andata al di là di una manifestazione di secondaria importanza. Perché?», si chiede una delle menti più illuminate del Novecento calcistico (e non solo) italiano.
Nel ritiro di Canzo, Tabanelli deve fare i conti con il forfait di Da Costa, che alza bandiera bianca nell’ultimo allenamento. Manca anche Nova ma rientra Magistrelli, pronto ad agire da ala sinistra con Domenghini sull’out opposto. L’altra finalista è il Torino, che in campionato ha chiuso con gli stessi punti degli orobici, 34. La gestione di Giacinto Ellena, arrivato a gennaio, non ha convinto più di tanto il nuovo patron, Orfeo Pianelli, futura icona granata. Proprio durante il ritiro prepartita, la squadra fa la conoscenza del tecnico della stagione successiva: si tratta di Nereo Rocco, campione d’Europa alla guida del Milan. Una mossa che, secondo alcune voci dell’epoca, può avere inficiato la serenità del gruppo granata, mentre quello orobico marcia compatto verso la meta.
Tabanelli e i suoi ragazzi vogliono quel trofeo, non lo vivono come una coppa secondaria ma come un grande obiettivo stagionale. In palio, oltre alla gloria, c’è anche la partecipazione alla Coppa delle Coppe dell’anno successivo. «L’Atalanta è una squadra seria, positiva, sana. Basta considerare il fatto che il sodalizio attinge in loco la maggioranza dei suoi elementi, diventando quindi un centro di produzione come potrebbero o dovrebbero esserlo tanti alti. Bergamo è città, è zona di gente quadrata e forte, nel morale e nel fisico. Questo è un riconoscimento che le va fatto in tono esplicito, anche come conseguenza della politica sportiva che ha voluto seguire», scrive Pozzo nell’analisi post finale. Una caratteristica che l’Atalanta presenterà spesso nella sua storia.

Il primo gol non sembra quasi provenire dal bagaglio tecnico di Domenghini. Punizione di Nielsen dalla trequarti destra, sul secondo palo spunta il numero 7 nerazzurro, in un inserimento di rara prepotenza. Per la velocità dell’arrivo sul pallone e la potenza dell’impatto, è un gol fuori dalla sua epoca. La rete di un giocatore modernissimo, che sta già attirando le attenzioni delle grandi italiane. L’esultanza, quella sì, è perfettamente coerente con i tempi. Non c’è nulla di artefatto nella gioia di “Domingo”, che scalcia il pallone in porta e si concede il saltello di chi non sa cosa fare, travolto soltanto dall’emozione. Nella ripresa, Domenghini raddoppia con una rete da opportunista, intervenendo sul sombrero di Magistrelli ai danni di Buzzacchera con una precisa conclusione mancina. Gli assalti granata sono vani, Pizzaballa è pazzesco su un sinistro al volo di Hitchens e “Domingo” può andare a calare il tris, stavolta con un’azione da ala tipica: dribbling a rientrare sul mancino, prima conclusione respinta, rimpallo fortunato per poi saltare il portiere e depositare in rete senza tanti fronzoli. La sua tripletta in finale di Coppa Italia resta l’unica su azione della storia: soltanto Giannini sarebbe riuscito a siglare tre gol nell’ultimo atto del torneo, ma tutti su calcio di rigore nella finale di ritorno con il Torino del 1993. Inutile, nei minuti conclusivi, la rete di Ferrini.
Le immagini della gara. A 0:55 il primo gol di Domenghini, a 1:57 il raddoppio, a 2:24 l’incredibile parata di Pizzaballa, a 2:41 il timbro del momentaneo 3-0
La stagione successiva, per l’Atalanta, si rivelerà particolarmente sfortunata. Con Carlo Alberto Quario in panchina al posto di Tabanelli, la “Dea” uscirà al primo turno in Coppa delle Coppe, vanificando il 2-0 dell’andata nel match di ritorno con lo Sporting. Tutta colpa di un infortunio patito da Pizzaballa: in un calcio privo di sostituzioni (e di calcolo doppio dei gol in trasferta), l’attaccante Calvanese si troverà costretto a indossare i guanti nel 3-1 per i lusitani, poi vincitori anche nella gara di spareggio. Domenghini lascerà l’Atalanta un anno più tardi, nel 1964, diventando un tassello della grande Inter, una colonna della Nazionale e vincendo un romanzesco scudetto con la maglia del Cagliari.
Molti, moltissimi anni più tardi, quel Fermo Favini ceduto qualche mese prima della vittoria in Coppa Italia sarebbe tornato in nerazzurro, per diventare l’architetto del vivaio orobico dopo aver svolto un lavoro strepitoso da responsabile del settore giovanile del Como. Un lavoro così grande da passare sopra anche al fatto di essere stato, prima e dopo la sua esperienza da calciatore con l’Atalanta, un punto di riferimento dei rivali storici del Brescia. Nessuno lo avrebbe chiamato più Fermo ma Mino, l’uomo del futuro. Non era in squadra in quel 1963 e non c’è più neanche ora, a distanza di 56 anni.
Quanto a “Domingo”, la speranza è quella di tornare a sentire squillare il telefono: «Sarebbe anche ora che la vincessimo questa Coppa Italia, son passati 56 anni e continuano a intervistarmi per quei tre gol».
Fonte: ultimouomo.it

By Gandalf